Memoria culturale
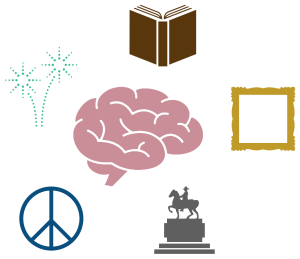 Assmann e Assmann definiscono la memoria culturale dal punto di vista degli studi culturali come „la tradizione dentro di noi, […] i testi, le immagini e i riti che si sono induriti nel corso delle generazioni, in secoli, persino in alcuni casi millenni di ripetizione, e che modellano la nostra coscienza del tempo e della storia, la nostra visione di noi stessi e del mondo“. (Assmann, J. 2006, 70)
Assmann e Assmann definiscono la memoria culturale dal punto di vista degli studi culturali come „la tradizione dentro di noi, […] i testi, le immagini e i riti che si sono induriti nel corso delle generazioni, in secoli, persino in alcuni casi millenni di ripetizione, e che modellano la nostra coscienza del tempo e della storia, la nostra visione di noi stessi e del mondo“. (Assmann, J. 2006, 70)
La triade della memoria
Questo termine, utilizzato principalmente nel discorso sulla memoria negli studi culturali, fa parte di una triade concettuale che, secondo Aleida Assmann, descrive forme fondamentalmente diverse di memoria:
– memoria individuale
– memoria comunicativa (sociale)
– memoria culturale (cfr. Assmann, A. 2006, 13).
Forme di memoria
Mentre la memoria individuale di una persona è piena di ricordi impliciti ed espliciti, cioè autobiografici, i ricordi sono conservati anche attraverso l’interazione con gli altri nella memoria collettiva, cioè nella famiglia, in un gruppo sociale o nella società nel suo complesso. Le tradizioni comunicative, cioè orali, vengono trasmesse di generazione in generazione.
Il sociologo francese Maurice Halbwachs descrive così il rapporto tra memoria individuale e società: „Il più delle volte ricordo perché altri mi spingono a farlo, perché la loro memoria viene in aiuto alla mia, perché la mia attinge alla loro. Almeno in questi casi, non c’è nulla di misterioso nella memoria“ (Halbwachs 1966, 20 s.).
Tuttavia, „i nostri ricordi non sono solo socialmente, ma anche culturalmente <<incorporati>>“ (Assmann, J. 2006, 69). Testi, immagini, cose, simboli e riti formano la memoria culturale e sono la base della nostra identità culturale. I portatori di queste tradizioni culturali sono „i supporti di memorizzazione esterni e le pratiche culturali“ (Assmann, A. 2006, 19), che conservano lingua, immagini, voci e suoni. Infatti, „solo i siti e i media di archiviazione trasformano una memoria comunicativa in una memoria veramente culturale“ (Reichwein 2018). (Reichwein 2018)
Storia e identità
Ma come si determina ciò che ricordiamo e ciò che dimentichiamo? I circoli dell’AfD invocano una „svolta di 180 gradi nella politica della memoria“ e marginalizzano l’Olocausto come un „nido di uccelli“. Viene denunciato il cosiddetto „culto della colpa“ dei tedeschi e quindi la memoria culturale viene messa sempre più in discussione.
Diventa chiaro che la memoria culturale non è statica. È soggetta a dinamiche e cambiamenti che devono essere discussi e negoziati nella società nel suo complesso. Infatti, „ciò che viene ricordato e ciò che viene dimenticato è in larga misura modellato, organizzato e ricostruito“ (Reichwein 2018).
Letteratura
Assmann, Aleida (2006): Spazi di memoria. Forme e trasformazioni della memoria culturale. 3a ed. Beck: Monaco di Baviera.
Assmann, Jan (2006): Thomas Mann e l’Egitto. Mito e monoteismo nei romanzi di Joseph. Beck: Monaco di Baviera.
Halbwachs, Maurice (1985): La memoria e le sue condizioni sociali. Suhrkamp: Berlino.
Reichwein, Marc (2018): Perché nessuna nazione può vivere senza memoria. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article177671164/Nation-und-Erinnerung-So-funktioniert-das-kulturelle-Gedaechtnis.html [13.11.2018].
