Concetto di divisione culturale della terra
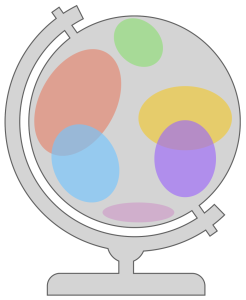 Il concetto di parte culturale della terra descrive una divisione spaziale della terra in diverse aree culturali, effettuata sulla base di caratteristiche definite. Secondo Newig, un didatta della geografia, le parti culturali della Terra sono definite come „collegamenti in una rete spazio-temporale mondiale di forme di vita umana di scala quasi continentale, basati sul loro ambiente naturale“ (Newig 1999). Lo scopo del concetto è quello di identificare gli spazi in cui vivono culture e comunità uguali o simili e di raggrupparli in modo da delineare gli spazi culturali più ampi.
Il concetto di parte culturale della terra descrive una divisione spaziale della terra in diverse aree culturali, effettuata sulla base di caratteristiche definite. Secondo Newig, un didatta della geografia, le parti culturali della Terra sono definite come „collegamenti in una rete spazio-temporale mondiale di forme di vita umana di scala quasi continentale, basati sul loro ambiente naturale“ (Newig 1999). Lo scopo del concetto è quello di identificare gli spazi in cui vivono culture e comunità uguali o simili e di raggrupparli in modo da delineare gli spazi culturali più ampi.
Emersione e variabilità del concetto
Il concetto è stato descritto per la prima volta da Kolb nel 1962 e nasce dalla ricerca spaziale della geografia. È nato dall’esigenza naturale di trovare un modo per orientarsi negli spazi e per definire la propria posizione, perché „ogni essere umano ha bisogno e sviluppa una visione geografica del mondo in cui classificare le sue informazioni di base, ma anche le molte nuove informazioni che si aggiungono ogni giorno“ (ibid., 7). Per consentire la classificazione, sono necessarie caratteristiche descrittive in grado di definire gli spazi. A causa di una moltitudine di concetti diversi, questi variano a seconda dell’autore e lasciano spazio a diversi approcci di classificazione.
Kolb ha sviluppato un concetto che definisce dieci parti culturali della terra e sostituisce così il pensiero sui popoli della geografia del dopoguerra (cfr. Stöber 2001, 138), „tuttavia si è astenuto dall’implementazione cartografica del suo tentativo di classificazione“ (ibid.).
Il concetto di Newig del 1986 classifica in base alle caratteristiche di „religione o ideologia; lingua, scrittura, legge; colore della pelle (razza); economia [e] situazione“ (Böge 1997, 323), da cui sono emerse le parti culturali terrestri Anglo-America, Australia, Europa, America Latina, Oriente, Asia orientale, Russia, „Africa nera“ (da allora ribattezzata Africa subsahariana), Asia meridionale e Sud-est asiatico (Reinke/Bickel 2018, 2).
Come Kolb e Newig, anche Huntington ha sviluppato nel 1996 un approccio alla classificazione che è uno dei più noti in letteratura (cfr. Stöber 2001, 138). Strettamente legato al suo articolo Scontro di civiltà, Huntington divide la terra in otto aree culturali le cui caratteristiche sono „elementi oggettivi come la lingua, la storia, la religione, i costumi, le istituzioni […] e] l’identificazione soggettiva della gente con essa“ (Huntington 1996, 28). In sostanza, il suo approccio è simile a quello di Kolb, ma pone maggiore enfasi sulla suddivisione in base alle visioni del mondo (cfr. Stöber 2001, 138).
Valutazione del concetto di terra culturale
Per molti anni, il concetto di terra culturale è stato fonte di dibattito sia in geografia sia in altre discipline. A causa di una moltitudine di approcci diversi, è stato ripetutamente oggetto di critiche, che per molto tempo sono state rivolte in particolare al concetto di Newig. Secondo Popp, è fondamentalmente problematico dividere le culture perché non esiste un modo chiaro per definire dove iniziano o finiscono le aree culturali (cfr. Popp 2003, 21). Tuttavia, è particolarmente importante che termini come cultura e spazio siano definiti chiaramente in anticipo, per essere consapevoli dell’ampiezza dei concetti.
La critica principale di Popp è che il concetto di terra culturale di Newig promuove il „pensiero a mosaico“ (ibid., 29) e può essere assunto come ideologia. Sulla base della rappresentazione cartografica, egli suggerisce che le aree culturali devono essere considerate separate l’una dall’altra e che non esistono forme di transizione. Inoltre, il nome „Africa nera“ è discriminatorio e, come il nome „Oriente“, riflette una visione eurocentrica. „Le terre culturali [di conseguenza] hanno una stretta somiglianza con gli stereotipi nel loro carattere espressivo, che, sebbene ci sia un grano di verità nella valutazione, si rapprendono facilmente in lamine stereotipate“ (Popp 2003, 37).
La letteratura
Böge, Wiebeke (2011): Kulturraumkonstrukte als zeitgebundene Weltbilder. In: Geografia e scuola 33, 4-8.
Böge, Wiebeke (1997): Die Einteilung der Erde in Grossräume: Zum Weltbild der deutschsprachigen Geographie seit 1871. Arbeitsergebnisse und Berichte zur wirtschafts- und sozialgeographischen Regionalforschung. Heft 16. Hamburg: Institut für Geographie der Universität Hamburg.
Dürr, Heiner (1987): Kulturerdteile: Una „nuova“ teoria dei dieci mondi come base per l’insegnamento della geografia? In: Geographische Rundschau 39, 228-32.
Newig, Jürgen (1999): Il concetto di Terra Culturale. https://www.kulturerdteile.de/kulturerdteile/ [01.08.2019].
Newig, Jürgen (1986): Tre mondi o un solo mondo: le parti culturali della terra. In: Geographische Rundschau 38, 262-267.
Popp, Herbert (2003): Il concetto di parti culturali della terra in discussione – l’esempio dell’Africa. Discorso scientifico – rilevanza per l’insegnamento – applicazione nelle lezioni di geografia. Studi di contatto di Bayreuth sulla geografia. Vol. 2. Bayreuth: Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth.
Reinke, Christine/ Bickel, Jens (2018): Infoblatt Kulturerdteile. Lipsia: Klett.
Stöber, Georg (2001): „Kulturerdteile“, „Kulturräume“ und die Problematik eines „räumlichen“ Zugangs zum kulturellen Bereich. In: ders. (a cura di): Culture straniere nell’insegnamento della geografia: analisi – concezioni – esperienze. Studi sulla ricerca internazionale sui libri di testo. Vol. 106. Hannover: Hahn, 138-154.
Stöber, Georg (2011). I concetti di spazio culturale nei curricula, nei libri di testo e nell’insegnamento. In: Geographische Rundschau 33, 15-26.
